In queste settimane abbiamo celebrato con grande gioia l’avvento delle unioni civili. Profumo di fiori d’arancio, di una prima esigua vittoria, di riconoscimento. Abbiamo parlato di tante coppie felici: di Franco e Gianni, insieme da 52 anni (LEGGI QUI), di Elena e Cristina (LEGGI QUI), le prime di Milano, di Michel e Silviu, che hanno incontrato problemi di nullaosta, ma che ora hanno risolto tutto e si uniranno presto (LEGGI QUI).
Tutte le storie sono diverse e non tutte le storie hanno il lieto fine. Se Margherita è riuscita a sposarsi poco prima di arrendersi alla malattia (LEGGI QUI), Tiziano e Andrea non sono riusciti a vincere la battaglia contro il tempo.
Avevo posto a Tiziano alcune domande sulla sua storia con Andrea. Su quando e come si fossero conosciuti, su come erano riusciti a essere coppia pubblicamente, pian piano negli anni. E di come avessero affrontato il male incurabile di Andrea.
Ne è nato un flusso di coscienza insieme disperato e vivo, una testimonianza struggente di una storia italiana, che in redazione abbiamo deciso di condividere per intera con voi.
LA NOSTRA STORIA
Nel 2003 vivevo per motivi di lavoro a Firenze. A settembre avevo conosciuto un ragazzo. Inizialmente sembrava che la cosa funzionasse ma, un paio di settimane dopo, lui si tirò indietro e, per evitare di incontrarlo in qualche locale gay della città, quella domenica del 26 ottobre decisi di andare a Bologna. A Bologna andai in sauna ed è lì che ho conosciuto Andrea, il posto forse meno idoneo per trovare un compagno.
Abbiamo passato il pomeriggio assieme. Andrea era sordo dalla nascita, ma leggeva perfettamente il labiale e, sebbene con una voce un po’ alterata, parlava perfettamente in un ottimo italiano. Da quella sera cominciammo ad inviarci una serie interminabile di sms. La domenica successiva venne lui da me a Firenze e giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, nacque una storia troppo bella. La nostra.
In quel periodo i suoi genitori ancora non sapevano della sua omosessualità, ma su consiglio di sua sorella rese nota la cosa a mamma e papà raccontando anche di me. La mamma fin da subito prese la cosa abbastanza bene (cuore di mamma), il babbo evitò di parlargli per una settimana, forse più per imbarazzo che per altro. Ricordo che Andrea soffriva molto per quel silenzio: lui adorava i suoi genitori.
Poi, come spesso per fortuna accade, la cosa rientrò ma l’accordo era che loro non avevano intenzione di conoscermi.
Andrea lavorava già da quasi 20 anni come perito agrario. Con i suoi risparmi e un piccolo aiuto da parte dei suoi genitori (mese dopo mese restituito fino all’ultimo euro) comprò a maggio 2004 un bell’appartamento all’ottavo piano di un condominio a Castel Maggiore, alle porte di Bologna, dove era nato e aveva sempre vissuto. Era arredato alla bene meglio utilizzando parte di mobili vecchiotti presi da una mansarda di proprietà dei genitori, ma per noi era una reggia! Io lavoravo sempre a Firenze e facevo il pendolare lunedì/venerdì. Il venerdì sera arrivavo a casa e la sua mamma, benché ancora non avesse intenzione di conoscermi, ci preparava la cena: antipasto, primo, secondo, contorno e dolce. Andrea passava da loro e ritirava tutto in contenitori: la cena era preparata, ma loro non volevano ancora conoscermi. Poi quattro anni fa lasciai Firenze e finalmente tutte le sere ci ritrovavamo a casa. La mattina ci si alzava, doccia, barba, una tazza in due di caffè latte e poi via al lavoro, sempre col sorriso sulle labbra certi che la sera, alle 19,00, ci saremmo ritrovati. E a letto io dormivo sulla sua spalla destra abbracciati. Ero in quella posizione la notte del primo febbraio di quest’anno quando sotto la sua ascella sentii un bitorzolo: un linfonodo. Raggelai. E lui d’istinto mi disse: “Lascia stare!“.
Sono passati anni felici fatti di lavoro, tanta serenità, belle vacanze in giro per il mondo. Il sabato sera uscivamo spesso a cena fuori e poi di corsa a casa sul nostro divano a vedere un film in DVD. Al cinema non potevamo andare, perché i film al cinema non sono sottotitolati, mentre i DVD ringraziando il cielo sì. Il divano per noi era un’istituzione: al sabato ma anche negli altri giorni dopo cena si guardava un po’ di TV o si leggeva un libro. Lui seduto, io coricato con la testa sulle sue gambe (sì lo ammetto: Andrea mi ha viziato molto). Ora io sul divano non siedo più. Non ce la faccio.
LE NOSTRE FAMIGLIE
Poi venne il giorno in cui la mamma accettò di incontrarmi. In quel periodo Andrea era Presidente dell’Ente Sordi per la provincia di Bologna ed aveva organizzato una festa per bimbi sordi e non. Siccome Andrea aveva una nipotina, Claudia, allora ancora piccola (oggi sedicenne bravissima studentessa al liceo classico) venne anche lei con con mamma e nonna.
Marina, la sorella di Andrea (fa il medico), la conoscevo già. Il primo incontro con sua mamma fu di grande imbarazzo anche perché , mi sembrava una donna molto dura ed altera (non è vero: è una donna straordinaria, d’una bontà unica. Oggi 81 anni ma con un’energia di una cinquantenne).
Qualche mese dopo sua mamma disse che era ora che suo marito la smettesse di evitare di incontrarmi. Disse: “Oggi pomeriggio veniamo a trovarvi e la finiamo con questa farsa!“.
Era il primo novembre del 2005. Io e Andrea quella mattina eravamo andati al cimitero a fare visita ai suoi nonni ed al fratellino (Andrea anche lui, nato e morto prima di Andrea secondo. Aveva solo 9 mesi. Ora i due Andrea sono assieme nello stesso loculo) e uscendo dal cimitero incontrammo i suoi genitori: l’incontro era stato anticipato involontariamente di qualche ora. Mi presentai: “Sono Tiziano“. “Lo so” fu la risposta secca. Imbarazzo tra tutti e 4. Va beh, passò. La domenica successiva il suo babbo organizzò (e pagò) un pranzo in un bel ristorante: mamma, papà, sorella, cognato, nipote, Andrea e Tiziano. E da quel giorno sono entrato ufficialmente a far parte della sua famiglia.
Quando i suoi genitori festeggiarono il 50° di matrimonio ci fu una grande festa con invitati. Al ristorante avevamo una sala tutta per noi: tre grandi tavoli rotondi. In uno i loro amici di una vita, in un altro i parenti, nel terzo noi: i festeggiati con i due figli con consorti e nipote. Quello fu il momento in cui resero ufficiale a tutti che Andrea non aveva una moglie ma bensì un compagno e, se a qualcuno non andava bene, quella era la porta.
La mia famiglia invece è questa. Una ex moglie, persona meravigliosa, dalla quale sono divorziato, che si è risposata, abita e insegna inglese in un istituto tecnico sul Lago Maggiore. Una figlia eccezionale, anch’essa laureata in lingue, che vive a Milano per motivi di lavoro. Una sorella, vedova da pochi anni e una nipote sposata che vivono a Piacenza, mia città natale. 4 donne: tutte hanno conosciuto Andrea e se ne sono innamorate fin dal primo momento per la sua dolcezza e bellezza d’animo. Hanno sofferto con me quando Andrea si è ammalato e sono state al mio fianco durante la cerimonia funebre di commemorazione.
Un paio d’anni fa il babbo di Andrea ebbe una brillante idea. Nel suo giardino c’era un garage in muratura di circa 80 mq. “E se in questo garage facciamo un’abitazione per voi?“, ci disse. Perfetto! Cambio d’uso, ristrutturazione. Abbiamo seguito con eccitazione i lavori e mattone dopo mattone è venuta su una villetta bellissima che noi abbiamo arredata con mobili nuovi, scelti uno per uno. Con una cura maniacale. Siamo entrati nella nuova casa il primo maggio del 2015. Finalmente eravamo tutti riuniti, perché anche la sorella di Andrea con famiglia abita qui nell’appartamento sopra i genitori. Era un sogno! Andrea aveva (ed ha perché ci pensiamo noi ora) più di 800 piante grasse che amava e curava come figli, passando con loro tutto il suo tempo libero. In più aiutava il papà nella cura del giardino pieno di piante e fiori.
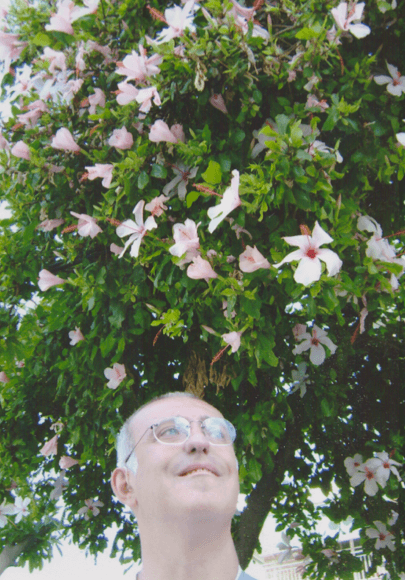
Stavamo bene. Cosa potevamo desiderare di più?
Io non ho mai usato la parola felicità perché mi ha fatto sempre paura, però mi piaceva dire che ero sereno. Una serenità che confinava con la felicità.
Serenità che è durata poco.
LA MALATTIA
Agli inizi di luglio 2015, due mesi dopo esserci trasferiti, Andrea ha cominciato a far fatica a dormire coricato: aveva dolori. Per più di due settimane ha dormito seduto su una sedia con la testa appoggiata ad un cuscino sul tavolo del soggiorno. Sì, è andato dal medico due volte. La prima, sentita la sua esposizione, il medico ha diagnosticato gastrite. Bene, tutti contenti, ha cominciato ad assumere medicinali adeguati. Ma la “gastrite” non passava. È tornato una seconda volta lamentando i continui dolori e chiedendo di fare un’ecografia, ma anche in questa occasione il medico ha minimizzato, invitandolo a continuare con i medicinali che stava assumendo. Mi sono stufato e ho detto che era giunto il momento di andare al pronto soccorso del Sant’Orsola: lì gli hanno fatto una serie di esami e, finalmente, l’ecografia. Responso: una macchia scura tra stomaco ed intestino delle dimensioni di un pompelmo. Ricovero immediato. Esami su esami. Il responso fu linfoma del tipo maligno, molto aggressivo, ma la dottoressa che ci diede l’infausta notizia ci disse di stare tranquilli perché le probabilità di guarigione erano del 65/70%, non c’erano metastasi in circolo e, strano a dirsi, è di più facile cura il linfoma maligno rispetto a quello benigno.
Terapia consigliata: 6 cicli di chemioterapia in day hospital due mattine consecutive al mese.
Ma dopo un ciclo e mezzo il linfoma era raddoppiato. Cercava in tutti i modi di difendersi.
Cambiamo protocollo: 6 cicli di chemio della durata di sei giorni ciascuno ogni 28 giorni ovviamente non più in day hospital. Dosi da cavallo. Da lì sono partite tutta una serie di infezioni: isolamento, cure pesanti con antibiotici e cortisonici. È iniziato un calvario dentro e fuori il Sant’Orsola. Lui era sempre più debole, sempre più magro. Ricordo un giorno di novembre, lui era a casa, ed io per tirarlo su di morale facevo il pagliaccio. Lui serio mi dice: “Ma la smetti di fare il cretino? Non vedi che sto morendo?“. Non ho detto niente, pioveva ma sono uscito in giardino sotto la pioggia ed ho pianto tutte le lacrime che avevo.
Il 30 dicembre nuovo ricovero in preparazione del terzo ciclo. Il 31 sera lo mandano a casa in permesso per dargli la possibilità di passare il capodanno in famiglia, ma alle 22 era già a letto. A mezzanotte io ero seduto sul “famoso” divano che piangevo.
Dopo il terzo ciclo di gennaio, il 2 febbraio era debolissimo, lo abbiamo trasbordato su una sedia a rotelle in ospedale per un esame PET. Sono entrato con lui. L’ho aiutato a spogliarsi, non si reggeva in piedi. Ho assistito all’esame.
Grazie, arrivederci, vi faremo sapere.
Ci hanno chiamati il 5 febbraio.
“Ci spiace, non c’è più niente da fare. È pieno di metastasi”. L’hanno ricoverato l’8 febbraio e da quella data non è più tornato a casa. A lui avevamo detto che si era aggravato, ma che appena si sarebbe ripreso gli avrebbero fatto una cura ancora più pesante e sarebbe guarito. Una misera bugia. C’ha creduto? Non lo sapremo mai.
Io avevo imparato dagli infermieri a lavarlo e cambiargli il pannolone e benché avesse scariche tremende, di un odore nauseabondo, l’ho sempre fatto con estrema delicatezza e dolcezza. Le “mele” non c’erano più, c’erano delle ossa ricoperte di un po’ di pelle e piaghe, piaghe, piaghe.
I medici ci dissero che gli avrebbero fatto, per tirarlo un po’ su, una cura di 6 flebo di vitamine a distanza di 10 giorni: forse il vero motivo era il bisogno di dimetterlo, visto che poi fu quello che ci imposero. Un malato terminale occupa un letto che alla Usl può servire. Nostro malgrado, abbiamo accettato il trasferimento.
Dopo un’esperienza tremenda a Villa Laura (tutto un reparto di soli anziani e malati di tumore in attesa di morire poco curati ed assistiti), abbiamo deciso di trasferirlo all’hospice Bentivoglio – Fondazione Serragnoli. Inizialmente la sua mamma rifiutava la soluzione dell’hospice perché da lì si entra e non si esce più da vivi, ma alla fine si convinse che era la soluzione ottimale per suo figlio.
L’hospice Bentivoglio lo paragonerei ad un hotel a 5 stelle. 30 camere tutte singole arredate con buon gusto. Il personale: angeli sempre disponibili, sempre con il sorriso sulle labbra.
Fin da subito Andrea ha voluto fare fisioterapia perché voleva riacquistare le forze. Voleva tornare a casa. Con il girello camminava per tutti i corridoi facendo una fatica immane, ma non mollava. Tutti i giorni, tutti i giorni. Ha smesso di camminare due giorni prima di morire, non ce la faceva più ad alzarsi: ginocchia gonfie ed aveva due piedi enormi. Li paragonerei a due ferri da stiro. E non esagero. Su due gambe che sembravano quelle di un fenicottero lunghissime e basta.
Il 20 marzo, domenica, alle sette del mattino ero già da lui. Dormiva; il respiro un po’ affannoso. Arriva l’infermiera, gli lascia le medicine, ma mi dice di lasciarlo dormire: non era poi così importante dargliele in quel momento. Alle otto arriva la colazione. Decido di svegliarlo. Dolcemente, accarezzandolo. Apre i suoi immensi occhi azzurri e mi sorride. Lo bacio. A mezzogiorno arrivano il suo papà e la sua mamma per darmi il cambio, per andare a casa a mangiare qualcosa. Nel frattempo arriva anche il suo pranzo e, saprò successivamente, mangia tutto e si addormenta fino alle 14,00 quando si sveglia e inizia la sua ultima battaglia. Alle 14,30 mentre mi sto dirigendo verso l’ospedale, suona il cellulare. È sua mamma: “Dove sei? Corri che Andrea sta morendo“.
Lo trovo seduto sul letto, respira a fatica, dice cose senza senso. Le ultime cose che ha detto sono: “Vorrei mangiare“. L’ho capito dopo: voleva dire “vorrei respirare“. Aveva i polmoni pieni d’acqua.
Arriva anche sua sorella. Ho pochi ricordi di quei minuti. A un certo punto uscito fuori dalla sua stanza piango urlando come un pazzo: “Vi prego salvatelo, vi prego salvatelo“. Alle 16,00 il medico ci chiama e ci dice che non sta rispondendo alla terapia, che sarebbe morto soffocato per enfisema polmonare per cui, se eravamo d’accordo, per non farlo soffrire, lo avrebbero addormentato, così dolcemente cuore e polmoni avrebbero smesso di lottare e altrettanto dolcemente sarebbe andato in pace.
Abbiamo dato il consenso.
In dieci minuti i suoi respiri sono diventati sempre più radi finché è finita.
Aveva 50 anni ed era alto un metro e novanta. In salute pesava 105 kg. Alla fine pesava poco più di 60 chili.
Ci hanno mandato fuori. Ci hanno chiesto un pigiama pulito. Lo hanno lavato, cambiato e ci hanno fatto rientrare. Era bello. Era ancora caldo. L’ho baciato sulle labbra. Quella notte non ho chiuso occhio.
A seguire le solite procedure: pompe funebri, l’abito bello da fargli indossare, il telefono che suonava incessantemente, le condoglianze, il funerale.
La chiesa era gremita; tanti miei colleghi, tanti suoi colleghi. Parenti, amici conoscenti. Tantissimi sordi; una suora che conosceva la lingua dei segni traduceva per loro quello che il prete diceva.
E’ seguita la tumulazione con il fratellino. Il suo babbo, che ha tenuto duro fino alla fine, ad un certo punto è scoppiato a piangere dicendo: “Non volevo piangere. Ma come si fa? Due figli ho portato al cimitero, due figli“. Da poco ha compiuto 83 anni.
LA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI
Durante il suo ricovero all’hospice in Parlamento si stava discutendo di una legge sulle unioni civili che stavamo aspettando da troppo tempo, ma i nostri politici non avevano fretta: che gli importa ad alcuni di loro di tanti Andrea e Tiziano? Sul comò c’è una foto mia e di Andrea, eravamo a Roma tanti anni fa a manifestare in favore dei PACS, anche allora non si fece nulla: questa volta non abbiamo potuto manifestare e scendere in piazza, Andrea stava già troppo male.
Anche noi avremmo voluto regolarizzare la nostra situazione, e sono contento che tanti ora lo stanno facendo. Un giorno Andrea mi disse: “Se avremo tempo faremo una bella festa; diversamente sarà una cerimonia veloce“. Ovviamente gli ho dato dello stupido: “Certamente sarà una grande festa perché tu guarirai!“. Non mi ha risposto, ma ha fatto un sorriso che aveva il sapore di una smorfia. Certamente il matrimonio ci avrebbe tutelati maggiormente, ma non abbiamo mai toccato a fondo l’argomento.
Benché io sia convinto che al Sant’Orsola qualche errore l’abbiano commesso (com’è possibile che fino a dicembre tutto andava per il verso giusto, mentre a gennaio tutto è precipitato?), devo spezzare una lancia in loro favore: non mi hanno mai detto: “Si accomodi, lei non ha titolo per stare qua“. E questo è successo ancora di più all’hospice. Tutti, ma dico tutti, molto carini con me. Tenendomi sempre informato sullo sviluppo della malattia. Non avevamo per fortuna un bisogno legale e materialistico di costituire un’unione civile, sono sempre stato trattato come il marito di Andrea: ma lo volevamo profondamente.
In fondo noi eravamo già sposati.
Pochi mesi dopo che stavamo insieme siamo andati in gioielleria e ci siamo comperati due fedine. Ce le siamo messe al dito e siamo usciti felici. Basta, noi eravamo sposati.
Quando se n’è andato, gliel’ho sfilata dall’anulare e l’ho infilata nella catenina che porto al collo assieme ad una medaglietta di Gesù e alla fede di mia mamma mancata tanti anni fa. Non potevo metterla al mio dito perché Andrea aveva dita più sottili delle mie.
Ora vivo nella nostra casa piena di ricordi che sono macigni, ma dei quali non posso fare a meno, la tengo pulita ed in ordine. Mi capita spessissimo di chiamarlo a viva voce.
Andrea aveva un’intelligenza unica; una cultura vastissima. Era amato ed apprezzato da tutti. Tengo ancora acceso il suo cellulare. Sul suo comodino ho messo i suoi occhiali, il suo apparecchio acustico, la mascherina che usava per dormire in presenza di luce, un giornaletto di sudoku (gli piaceva molto) che gli avevo comperato qualche giorno prima che ci lasciasse, con la sua matita e la gomma che usava per risolvere gli schemi. Ha risolto solo i primi cinque, non ha avuto il tempo per risolverne altri. Per terra, di fianco al letto, le sue pantofole.
Sull’avambraccio sinistro mi sono fatto tatuare una data: 20.03.2016. Alcuni amici non hanno condiviso questa scelta: “Potevi tatuarti la data in cui vi siete conosciuti“.
No, se avessi dovuto tatuarmi qualcosa di bello non sarebbe bastata tutta la superficie del mio corpo: non abbiamo mai avuto una lite o cose simili. Tutto veniva fatto di comune accordo.
Ho 62 anni. Cosa devo aspettarmi ancora di bello o di brutto dalla vita? Avevamo tanti progetti: continuare a viaggiare, prenderci un cane quando saremmo andati in pensione… E ora? Niente.
Tante persone mi dicono: “Sai, è presto… ci vuole tempo…”.
Io sorrido, non rispondo e penso alle parole di una canzone della Berté: “Se pesco chi un giorno ha detto ‘il tempo è un gran dottore’ lo lego a un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare“.
Vado al cimitero tutte le volte che posso. Ho comprato uno sgabello, mi siedo di fronte a lui e gli parlo, gli parlo, gli parlo. Ora finalmente riesce a sentirmi.











