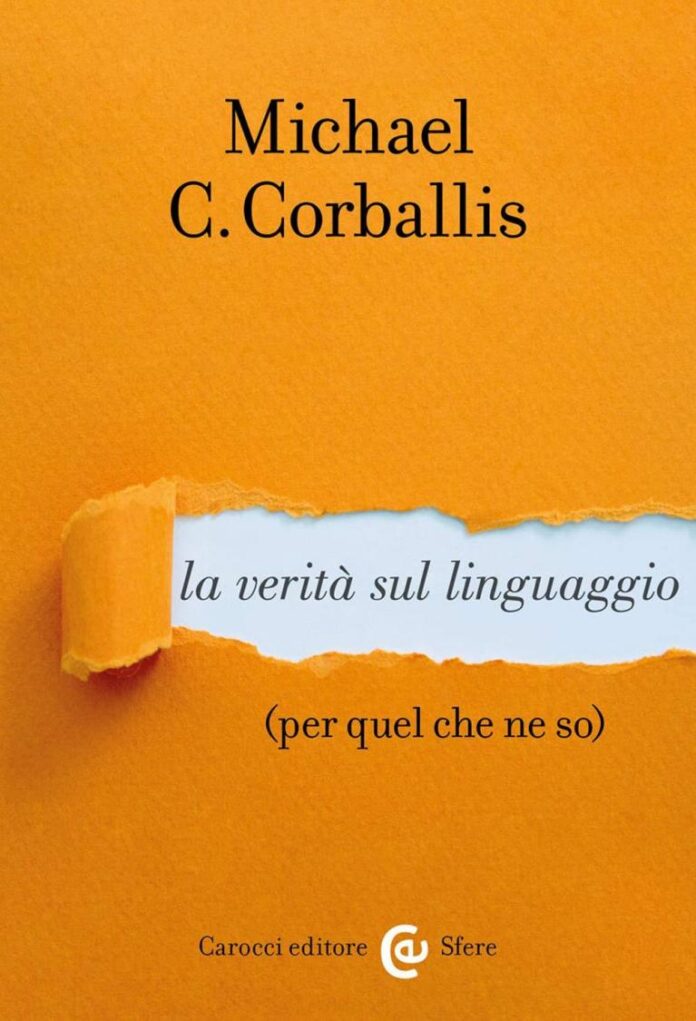A volte il confronto fra i titoli – o fra i sottotitoli – è curioso. L’ultimo libro di Michael C. Corballis, da poco in libreria – La verità sul linguaggio (per quel che ne so), Carocci – è la traduzione, ad opera Ines Adornetti, di The Truth about Language: What It Is and Where It Came From, University of Chicago Press, 2017.
Viene da chiedersi se il divario fra la cauta dicitura del sottotitolo italiano e la perentoria assertività di quello originale dipenda dalla volontà di uno dei due editori, o di entrambi: e a quale vada la preferenza dell’autore. Certo, quanto a copertina, la versione italiana vince di parecchie lunghezze.
L’origine del linguaggio è uno dei temi più affascinanti, sfuggenti e controversi della ricerca contemporanea. Nel variegato panorama degli studi – che vede mobilitata una platea interdisciplinare di linguisti, filosofi, psicologi, biologi, archeologi, antropologi, paleontologi, primatologi – spicca l’antinomia fra due posizioni fondamentali. Alcuni ritengono che il linguaggio umano si sia manifestato d’improvviso, in una sorta di esplosione (un big bang), come conquista esclusiva della specie Homo sapiens – se non addirittura di una particolare popolazione di Sapiens, dalla quale tutti noi discendiamo – e che di conseguenza la sua origine vada collocata in un’epoca compresa fra 100.000 e 60.000 anni fa. Altri pensano invece che il linguaggio sia il risultato di un lento sviluppo, svoltosi lungo il corso del Pleistocene: e che quindi riguarda l’intero genere Homo, inclusi non solo i Neandertaliani, ma anche l’antico e glorioso Homo erectus.
Corballis, neuroscienziato neozelandese già noto al pubblico italiano per due importanti studi – Dalla mano alla bocca. Le origini del linguaggio (Cortina, 2008); La mente che vaga. Cosa fa il cervello quando siamo distratti (ivi 2016): qui la mia recensione –, si schiera senza esitazioni nel secondo gruppo, che annovera tra le sue file i più convinti sostenitori del principio enunciato da Darwin in The Descent of Man, 1871: «La differenza mentale fra l’uomo e gli animali superiori, per quanto sia grande, è certamente di grado e non di genere».
Il dilemma è di grande rilievo. Dato il fortissimo investimento emotivo e simbolico sulla comunicazione verbale che da sempre contraddistingue le nostre culture, in gioco è la stessa idea di «uomo». Chi vede nella nascita del linguaggio un «Rubicone», ossia una soluzione di continuità abbastanza netta, salva qualche residuo di un’antica rivendicazione di eccezionalità ed esclusività che ieri contrapponeva l’uomo agli animali, ai «bruti» (e quindi, in sostanza, a tutto il resto del creato), e che oggi, più modestamente, si limita a tracciare una linea di confine tra l’umanità moderna e le altre specie umane e ominidi. Chi al contrario sostiene l’ipotesi di un’evoluzione graduale mette in rilievo quanto accomuna gli umani agli altri viventi: ed è chiaro che l’alternativa investe orizzonti ben più ampi di un dibattito disciplinare. Da profano, io mi sento decisamente più vicino alla seconda posizione, anche se meno drammatica e – come dire? – meno coinvolgente dal punto di vista narrativo. L’idea di un gruppo di Sapiens che grazie all’inedita risorsa del linguaggio articolato abbia la meglio sia su altre specie di umani, sia sugli altri Sapiens privi di favella, potrebbe essere il nucleo di un intreccio romanzesco; ma a me pare più plausibile che le cose non siano andate così. Resta, è vero, un dato problematico che ci fornisce la ricerca genetica: cioè la probabile discendenza della massima parte della popolazione mondiale da un gruppo di Sapiens abbastanza piccolo, artefice dell’ultima «uscita dall’Africa». Ma la spiegazione potrebbe essere ricondotta a fattori diversi, non dipendenti dall’evoluzione culturale (ad esempio, la casuale acquisizione di immunità rispetto a qualche categoria di agenti patogeni).

All’antinomia tra big bang (o «grande balzo in avanti») ed evoluzione graduale se ne affianca un’altra, di importanza non minore, che oppone la maggior parte della linguistica novecentesca – a cominciare dal suo esponente più illustre, Noam Chomsky – a una linea più recente, i cui esponenti principali sono l’israeliano Daniel Dor, di cui ho parlato a suo tempo su queste pagine e il californiano Daniel Everett (che ha legato il proprio nome, fra l’altro, allo studio della lingua di una popolazione amazzonica, i Pirahã). Schematizzando, l’alternativa è tra una concezione del linguaggio come manifestazione di regole innate, ovvero (in una versione più aggiornata e moderata) come modalità del pensiero, da un lato, e una concezione del linguaggio come prodotto di una tecnologia, e quindi come risultato di un apprendimento, dall’altro. Secondo quest’ultima ipotesi, a dare impulso allo sviluppo del linguaggio è stata la necessità pratica di condividere pensieri ed esperienze: dunque, un fattore esterno, non un mero processo neurologico. All’analisi delle posizioni di Chomsky, delle sue graduali concessioni a una visione evoluzionistica della genesi del linguaggio, nonché della sua ostinata difesa di una linea «eccezionalista» sempre più debole, Corballis dedica parecchie pagine; e anche in questo caso trovo le conclusioni del tutto persuasive.
Nel panorama di un’interpretazione darwiniana, Corballis si distingue poi per la chiarezza con cui sottolinea la differenza tra linguaggio e parola. La comunicazione verbale è solo una delle possibilità, e, nella storia del genere umano, non la più antica. Qui ritroviamo la tesi dell’importanza del linguaggio gestuale, che era al centro dell’argomentazione in Dalla mano alla bocca (From Hand To Mouth, 2002). Non c’è dubbio che i nostri parenti più prossimi (scimpanzé e bonobo) abbiano un fortissimo controllo della manualità, molto superiore al controllo sulle emissioni vocali; la lingua dei segni dimostra che gesti e mimica sono più che sufficienti a sostenere un linguaggio articolato; il predominio della parola non ha mai soppiantato del tutto i vari aspetti della comunicazione corporea. La gestualità, potremmo aggiungere, è un intero universo.
Nella fattispecie, la teoria gestuale sull’origine del linguaggio è oggi condivisa da vari altri illustri studiosi, quali Michael Tomasello e Michael Abib («ma anche da un non Michael, Giacomo Rizzolatti»). Affascinante è poi l’idea che il linguaggio rappresenti una sorta di estensione della cosiddetta «teoria della mente» (cioè della capacità di interpretare pensieri ed emozioni altrui). In tale contesto, difficile da sopravvalutare è una caratteristica del linguaggio su cui ha insistito in particolare Thomas C. Scott Phillips in un altro volume tradotto da Carocci, Di’ quello che hai in mente. Le origini della comunicazione umana (2017), cioè la sottodeterminazione: ogni atto comunicativo fa leva su procedimenti inferenziali.
C’è tuttavia un punto nel discorso di Corballis che non mi pare del tutto chiarito, cioè le ragioni della transizione dal linguaggio gestuale a quello vocale. Corballis sottolinea due aspetti: la costante del movimento («dal movimento del corpo e delle mani si passò a quelli del viso, per arrivare infine a quelli circoscritti all’interno della bocca») e la tendenza verso l’astrazione e la convenzione, largamente documentabile nella storia delle lingue dei segni («Il linguaggio verbale può […] essere visto come il punto finale del passaggio alla convenzionalizzazione e dell’aumento dell’efficienza»). A mio avviso, la spiegazione è insufficiente: qualcosa manca. E a colmare la lacuna si presta bene un’altra affascinante teoria sull’origine del linguaggio, formulata tempo fa dall’antropologa americana Dean Falk: cioè l’investimento sulla comunicazione vocale nel rapporto madre-piccolo, reso necessario dalla sopravvenuta impossibilità per le madri ancestrali di fare come le femmine delle grandi scimmie (i cui piccoli si tengono aggrappati alla pelliccia con quattro mani). Il contatto sonoro surroga il contatto fisico; il controllo sulle emissioni vocali, di conseguenza, si potenzia; alle esigenze della comunicazione articolata si potrà dunque far fronte, ove necessario, anche attingendo alle risorse della voce. E vorrei aggiungere che nessuna spiegazione del ricorso alla comunicazione verbale mi pare più persuasiva quanto quella proposta da Robin Dunbar, l’autore di Grooming, Gossip, and the Origin of Language (1997).
Ma c’è un altro aspetto della manualità che merita di essere ricordato, e che emerge con chiarezza dal libro di Corballis: il legame fra l’articolazione del linguaggio e lo sviluppo di tecniche di costruzione degli strumenti. Per produrre e utilizzare utensili occorre mettere in atto procedimenti che sottostanno anche all’evoluzione della grammatica, quali la combinazione di parti o la successione temporale delle operazioni.
Qui mi pare che la riflessione incroci sentieri già battuti dalla storia della scienza e della filosofia: penso ad esempio a un libro che molto mi colpì quando lo lessi, negli anni del liceo, Lavoro manuale e lavoro intellettuale nell’antica Grecia di Benjamin Farrington (Feltrinelli 1970). Sarebbe scorretto, peraltro, dimenticare il ruolo degli arti inferiori. Homo sapiens è una specie camminatrice. Non credo che i nostri progenitori avrebbero imparato a comporre lunghi discorsi se non avessero fatto anche – spesso, a lungo, e prima – l’esperienza di compiere lunghi spostamenti. Camminare e raccontare sono attività imparentate. In entrambe, è tutta questione di ritmo: non a caso, sia in latino sia in greco l’unità di misura della metrica è denominata «piede». Insomma: l’origine del linguaggio è una faccenda che chiama in causa tutto il corpo, bocca, cervello, volto, mani, piedi. E non è un caso se ci si sentiamo così impacciati, così menomati, oggi che a tanti di noi tocca dover parlare immobili davanti a una webcam.